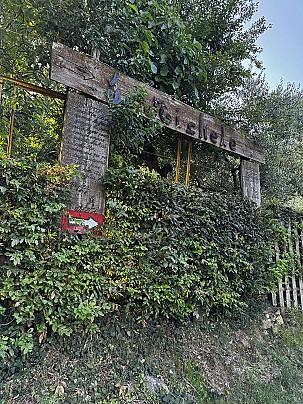Provezze
Caratterizzata da ampi vigneti e inserita in un anfiteatro morenico, offre un ambiente naturale suggestivo e ricco di biodiversità.
Provezze è una delle frazioni più antiche e significative del comune di Provaglio d'Iseo. Il territorio vanta una lunga tradizione agricola e, come molte località della zona, ha subito diverse influenze storiche. Il suo territorio agricolo, ricco e generoso, ha modellato nei secoli il paesaggio e lo stile di vita della comunità: vigne ordinate, campi coltivati, filari che seguono l’andamento naturale del suolo raccontano una lunga tradizione contadina fatta di impegno, stagioni, e conoscenza tramandata. Qui, l’agricoltura non è solo economia, ma cultura. Le attività agricole, in particolare la viticoltura, sono il cuore pulsante di un’identità locale che ha saputo rinnovarsi restando fedele alle proprie origini. Ogni angolo di Provezze parla del lavoro dei campi, delle cascine storiche, delle cantine, dei piccoli sentieri battuti dai contadini di ieri e di oggi. A differenza del territorio circostante, Provezze si distingue per la tranquillità della zona, le ampie aree verdi e la scelta urbanistica di collocare l’area industriale al di fuori del centro abitato. Le sue strade conservano un’impronta storica, attraversando quattro contrade che suddividono il territorio in piccoli borghi.
Il nome stesso sembra derivare dal latino "prope via", ovvero "vicino alla via", a testimonianza della sua posizione strategica lungo i percorsi che collegavano la pianura alla Valle Camonica e al lago d’Iseo. Già in epoca romana il territorio era frequentato, come indicano alcuni reperti rinvenuti nella zona. Ma è nel Medioevo che Provezze prende forma come comunità strutturata, attorno alla pieve e alle corti rurali. In questo periodo si sviluppa una società agricola viva, composta da piccoli proprietari, mezzadri e comunità religiose che esercitano un ruolo importante sia spiritualmente che economicamente.
Durante il periodo comunale e successivamente sotto la dominazione della Repubblica di Venezia, Provezze mantiene una certa autonomia nelle pratiche locali, pur restando legato alle vicende del più ampio territorio bresciano. La vita si svolge attorno alla terra, ai cicli agricoli, e alla religione, con la chiesa parrocchiale che diventa punto di riferimento per la comunità. Quest'ultima, edificata nel XVIII secolo su una struttura preesistente risalente al XVII secolo, la chiesa presenta una facciata articolata su due registri con lesene composite e nicchie contenenti statue di santi. Il portale marmoreo è sormontato da una lunetta affrescata. L'interno, a navata unica con cappelle laterali, è interamente decorato con volte a vela affrescate. Il presbiterio, rialzato e quadrangolare, ospita cantorie laterali, una delle quali contiene un organo realizzato nel 1864 da Giudici e Compagni.
Nei secoli successivi, Provezze continua a crescere mantenendo il suo carattere agricolo, e nei secoli XIX e XX affronta, come molti centri rurali lombardi, le sfide dell’industrializzazione e dello spopolamento. Tuttavia, la frazione riesce a conservare un’identità forte, grazie alla coesione sociale e a una grande attenzione per la memoria storica.
Lungo la via principale, si affacciano gli edifici sede dei principali servizi pubblici: il Centro Servizi, che ospita la Scuola Materna Statale, gli ambulatori, la Sala Civica e il Campus, che comprende la Scuola Elementare.
Imponente nella sua sobria eleganza, la Chiesa Parrocchiale di San Filastrio domina il centro del paese, divenendone punto focale sia religioso che urbanistico. L'attuale edificio, risalente al XVIII secolo, fu costruito su una precedente struttura seicentesca, testimoniando la continuità della fede e della centralità della vita parrocchiale nella comunità di Provezze. La facciata, scandita da lesene composite che delimitano tre settori verticali, si sviluppa su due registri, secondo il gusto tardo barocco lombardo. Nelle nicchie laterali sono collocate statue raffiguranti santi locali, probabilmente San Filastrio e San Rocco, molto venerati in zona. Il portale d’ingresso, in marmo scolpito, è sormontato da una lunetta affrescata, che raffigura una scena della vita del santo titolare, creando un collegamento visivo immediato tra il fedele e la figura protettiva del santo. L’interno della chiesa è a navata unica, con cappelle laterali dedicate ai principali culti devozionali locali. L’ambiente è impreziosito da volte a vela affrescate, probabilmente opera di artisti attivi nella zona tra Settecento e Ottocento, che rappresentano motivi floreali e scene sacre. Le decorazioni pittoriche contribuiscono a creare un’atmosfera raccolta ma luminosa, dove arte e spiritualità si intrecciano armoniosamente. Il presbiterio, rialzato e di forma quadrangolare, ospita cantorie lignee laterali, di cui una custodisce un pregevole organo realizzato nel 1864 dalla ditta Giudici e Compagni di Bergamo, celebre per la qualità e la raffinatezza dei suoi strumenti. Lo strumento è tuttora funzionante ed è utilizzato durante le principali celebrazioni liturgiche e concerti sacri. Alle spalle dell’altare maggiore si trova un coro ligneo intagliato, probabilmente di epoca tardo barocca, che testimonia la cura artistica riservata a questo spazio sacro. Alcune tele di buona scuola lombarda, raffiguranti episodi della vita di San Filastrio e di altri santi venerati localmente, completano l’apparato iconografico dell’edificio. La chiesa, oltre alla sua funzione religiosa, ha sempre svolto un importante ruolo aggregativo per la popolazione di Provezze: centro delle celebrazioni liturgiche, ma anche luogo simbolico d’identità e memoria collettiva. Le sue campane, ospitate nella snella torre campanaria, segnano ancora oggi il ritmo del tempo e delle giornate del paese, come un richiamo continuo alla storia e alle radici spirituali della comunità.
Un elemento architettonico di grande rilievo per il territorio è Villa Floris, situata nella contrada di Sergnana. Questo piccolo borgo, pur avendo origini antiche – forse addirittura romane – si sviluppa come nucleo abitato solo nel corso del Cinquecento, proprio attorno alla villa e alla chiesetta dedicata a San Rocco, il santo maggiormente invocato, dal Medioevo in poi, contro il flagello della peste. La chiesa fu edificata a partire dal 1576, anno tristemente noto per la peste di San Carlo, e completata attorno al 1630, durante la terribile epidemia descritta anche ne I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Le prime tracce della villa risalgono indicativamente al Trecento, quando venne costruita con una funzione militare: a quell’epoca esisteva infatti solo la torre, tuttora visibile nelle sue forme pressoché originarie, che svolgeva un ruolo difensivo lungo il confine con i fondi della famiglia Oldofredi. Questa torre è una delle poche strutture difensive della Franciacorta ad essere scampata agli abbattimenti del Quattrocento, quando molte fortificazioni persero la loro funzione strategica. Alla fine del Quattrocento fu aggiunto alla torre il corpo di fabbrica che oggi costituisce il nucleo centrale della villa. Si tratta di un tipico fabbricato rurale, simile alle storiche cascine della fascia collinare bresciana, caratterizzato da una doppia fila di arcate che si sviluppano nel portico al piano terra e nella loggia al piano superiore. Fu però la ricca famiglia bresciana degli Averoldi, proprietaria del fondo a partire dai primi anni del Cinquecento, a trasformare l’intero complesso in residenza privata. Le tracce degli interventi edilizi operati in quell’epoca sono ancora oggi visibili sia nella torre, sia nel corpo centrale. Nel 1540 il complesso passò alla famiglia Caprioli, grazie al matrimonio tra Lorenzo Caprioli e Nostra Averoldi, sorella di Giovanni Averoldi. La villa rimase di loro proprietà per tutto il Seicento. Tra la fine del Settecento e la metà dell’Ottocento, l’edificio venne acquistato dalla nobile famiglia Soncini, già proprietaria di terreni nella frazione di Provezze. Furono loro a promuovere importanti modifiche alla struttura, tra cui la costruzione di una barchessa sul lato occidentale: un’aggiunta significativa, che testimonia la vocazione prevalentemente agricola assunta dalla villa in quel periodo. La barchessa, tipico edificio di servizio rurale, aveva infatti la funzione di ospitare ambienti di lavoro e di separare lo spazio riservato ai contadini da quello padronale. In seguito, la proprietà passò ai Nava, poi ai Franceschetti e infine alla famiglia Floris, attuale proprietaria della villa.
Bibliografia
AA.VV, La mappa del tesoro. Materiali per un museo del territorio, Associazione culturale San Pietro in Lamosa, Provaglio d’Iseo, 2004.
F. Lechi, Le dimore bresciane, volume IV, Edizioni di Storia Bresciana, 1975.
F. Ferrari e G. Riina, Progetto di conservazione della torre dell’antica rocca di Sergnana, tesi di laurea, A/A 1997-1998.









-thumb.jpg)